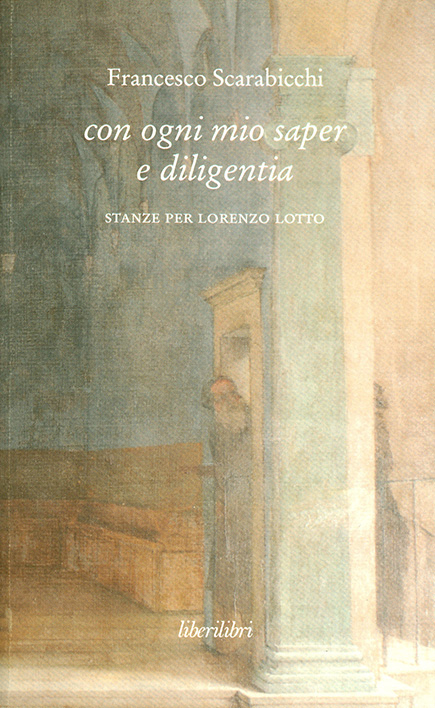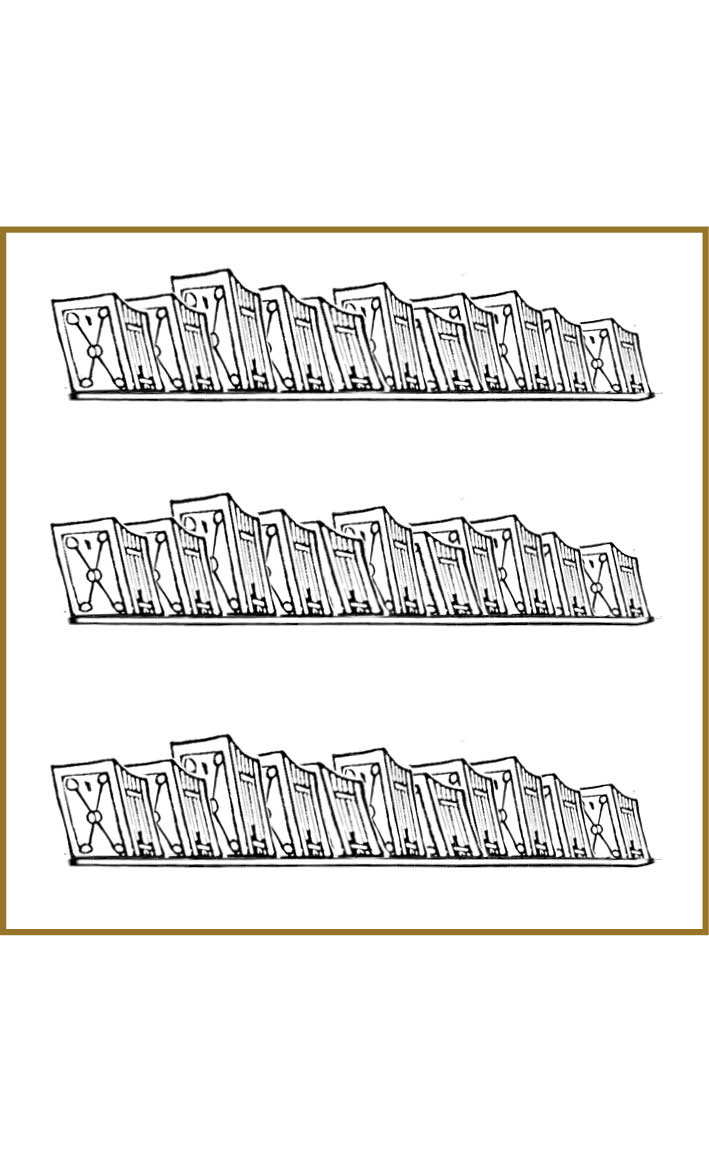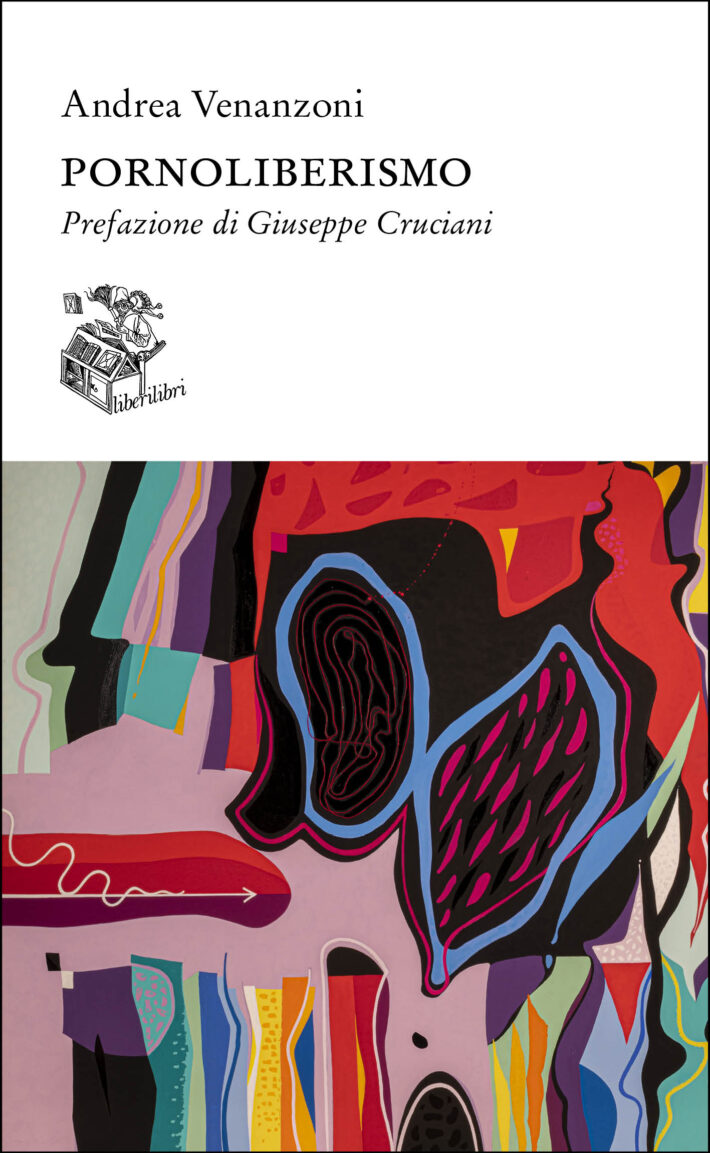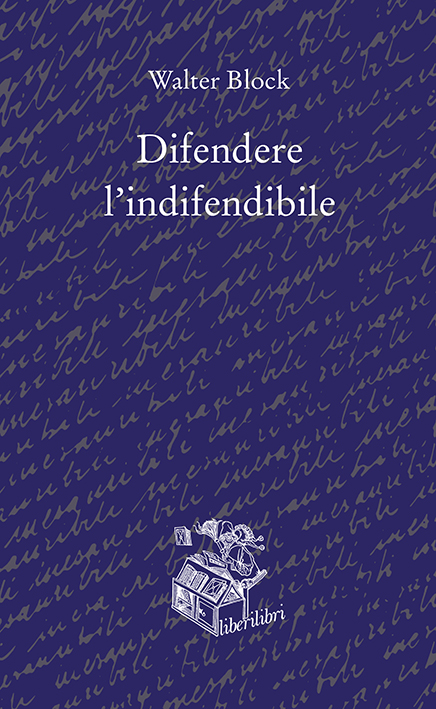I paesaggi d’Italia, rifatti dai poeti di Massimo Onofri, «Avvenire», 17 maggio 2014, pag. 22
Roberto Longhi lo pensava di sicuro: che ogni cielo, in Italia, avesse il suo pittore. Verità tanto più persuasiva, proprio perché integrabile con un’alt1a, che ha avuto una eclatante evidenza soprattutto nel Novecento anche dialettale: che quello stesso cielo avesse anche il suo poeta. Discorso, questo, che ha trovato conferma – qualcuno lo ricorderà – in una bella antologia che il poeta Plinio Perilli approntò, nel 1990, per l’editore Sansoni: Storia dell’arte in poesia. Dov ‘era assolutamente evidente che i poeti italiani – proprio in un senso rigorosamente longhiano – siano stati capaci di fornirci assai spesso, nei loro versi, delle vere e proprie equivalenze verbali dei fatti artistici. Un sistema di equivalenze che diventa assai suggestivo, acquistando notevole valore gnoseologico, quando lavora in convergenza per restituirci una storia del paesaggio italiano e degli italiani. Mi tornava in mente tutto questo, mentre sfogliavo l’intenso libro che Francesco Scarabicchi ha pubblicato per le edizioni Liberilibri di Macerata, con una nota di Massimo Raffaeli e una postfazione di Michele Polverari, intitolato Con ogni mio saper e diligentia, stanze per Lorenzo Lotto.
Raffaeli ha ragione quando dice che questi di Scarabicchi «non sono versi di illustrazione a Lorenzo Lotto»: «Lotto qui non è una icona e tanto meno una sequenza pittorica ma, semmai, è il nome di una estrema spoliazione, di una verità perseguita al massimo prezzo, quello del raccoglimento interiore e di una forza tutta implosa nel meditare e nel fare in silenzio, come dopo una rinuncia che abbia abolito il troppo e il vano o ne abbia appurata la micidiale gratuità». È vero: il Lotto che qui imposta la voce, raggiunge vertici d’intensissima spiritualità, capace com’è, nella nuda e esatta concentrazione della parola, di restituirci un’acutissima nostalgia di Dio attraverso, magari, una riflessione sulla luce dei suoi quadri. Ecco: «C’è Dio nei miei dipinti, oltre quei corpi⁄ e quelle forme esatte? C’è lui o è solo vuoto/ lo spazio in cui m’annego un’altra volta/ accosto al domandare?/ Se questa solitudine contiene/tutta la pena e tutto lo spavento, / allora perché mai l’intatta luce/accende di bellezza donne e santi,/ pastori e pellegrini,/ adultere ed arcangeli,/ sacra famiglia e orafi,/ martiri e gentiluomini?».
Epperò anche lo scarno e meditativo, l’essenziale Scarabicchi, non può non cedere, ancora attraverso la luce, e nelle parole di Lotto, a quell’ossessione del paesaggio cui raramente sfugge un pittore o un poeta italiano. Dico Lotto, forse il più intensamente psicologico, il più interiormente mobile dei pittori del Cinquecento: «Mi somiglia la luce di Venezia/ nell’ultimo di aprile,/ si fa verde del mare nel canale/ e taglia nubi alte, le distende».
Anche Maria Pia Quintavalla ne I compianti pubblicato di recente da Effigie – ne ha parlato qui Pierangela Rossi – per fissare il ricordo del padre morto, non può non riferirsi alla sua Parma, rimpaginata, appunto, nelle visioni di Correggio. In effetti, il Novecento che abbiamo alle spalle è stato in poesia, da Diego Valeri a Andrea Zanzotto, proprio mentre la pittura s’andava facendo astratta e concettuale (e nemica feroce della bellezza e della natura). un secolo assai impegnato nella costituzione del paesaggio, secondo quelle modalità che Rosario Assunto – filosofo dimenticato e controcorrente nel tempo corrusco delle ideologie- ha studiato e codificato in un libro unico e memorabile: Il paesaggio e l’estetica, apparso, tra sberleffi lazzi e accuse di reazionarismo, nel 1973.
Se la Natura ha potuto ritrovare ordine e bellezza, ricostituita entro determinati e riconoscibili paesaggi, in concomitanza con una sempre più vigile coscienza ideologica, ciò è stato possibile anche grazie alla parola dei poeti, di fatto gli ultimi grandi figurativi nella crisi conclamata della pittura di realtà. La Liguria sarebbe oggi quella che per noi è senza Montale? E Livorno senza Caproni? E Grado senza Biagio Marin?
Vetrina. “Con ogni mio saper e diligentia” di Valentina Nencini, «www.scenecontemporanee.it», 12 dicembre 2013
Accostarsi alla poesia di Francesco Scarabicchi presuppone la volontà di lasciarsi raccontare una storia. La sua poesia, naturalmente, procede di pari passo con l’osservazione della pittura di Lorenzo Lotto a cui è dedicata. Ma va oltre alla mera descrizione di quella pittura perché nei suoi versi c’è la volontà di raccontare un uomo, lo svolgersi della sua vita, la sua solitudine.
Per chi non ha dimestichezza con la biografia di Lotto vale la pena ricordare che l’artista veneto è stato uno dei maggiori rappresentanti della pittura del Cinquecento, ma la sua fama è una questione relativamente recente (la sua riscoperta risale alla fine dell’Ottocento ma si protrae fino agli anni Novanta dello scorso secolo, quando una serie di studi approfonditi hanno contribuito a palesarne la pregevole tecnica e la grande abilità pittorica che ne fanno un artista di primo piano del suo tempo) mentre all’epoca della sua attività tutto l’apprezzamento andava al ben più noto Tiziano. Lotto rimase un pittore provinciale, minore, come dimostra anche la conclusione della sua vita nella Santa Casa di Loreto dove si spense quasi sconosciuto.
Scarabicchi, con i suoi versi, riesce a conciliare la figura dell’uomo e dell’artista, ponendo continuamente in evidenza il divario tra le grandi doti pittoriche del Maestro veneto e la sua vita solitaria e isolata, fatta di insuccessi e delusioni professionali. L’abilità del poeta, peraltro non nuovo ad operazioni analoghe, è evidente soprattutto perché spinge il lettore a voler immediatamente recuperare il testo visivo a cui l’autore fa riferimento, rendendo poesia e pittura un unicum indistinguibile che si giustifica ed arricchisce in un reciproco scambio.
Un’altra caratteristica preponderante di queste stanze in onore di Lorenzo Lotto è il senso del sacro che emerge, poesia dopo poesia, in maniera progressivamente sempre più evidente, soprattutto man mano che la lettura va avanti e si prende dimestichezza con il testo; e, anche in questo caso, è impossibile non collegare questa caratteristica alla vita del pittore, quando gli insuccessi professionali lasciarono il posto ad una vocazione religiosa sempre più evidente che lo portò a dedicarsi, negli ultimi anni di vita, alla contemplazione e alla preghiera.
Come nota a margine, che esula dal testo in oggetto ma che è pertinente all’argomento, vale la pena evidenziare come l’accostamento di diverse forme artistiche – in questo caso poesia e pittura – possa rappresentare un modo per riscoprire opere pregevoli ed osservarle sotto una luce nuova che contribuisce ad arricchire entrambe. Ben vengano, quindi, operazioni simili, purché all’insegna dell’alta qualità, come nel caso delle stanze di Scarabicchi.
Con ogni mio saper e diligentia, di Gian Paolo Grattarola, «Mangialibri.com», 17 giugno 2014
Il poeta riconosce con acuta e dotta introspezione nell’arte pittorica di Lorenzo Lotto la fragilità dell’esistere, ne avverte il fardello di una sorte dolorosa e il lacerante avvertimento della condanna a un esilio che non è solo materiale: “Ma questo chiaro che m’invade e tiene/ è misura di me e del turbamento/ che provo ad ogni passo, in ogni dove,/ ferito da mio essere straniero/ all’isola del mondo, a un universo/ di cui conosco il cielo e le alte stelle.” In maniera tale da sentire lancinante la consistenza di una condizione rispecchiata, l’autore traccia quelle tangenze di sensibilità, che nel pittore sono sfumature della virilità nel languore, della forza nel disfacimento, trasponendole in un linguaggio poetico in cui anche ciò che non è affine diviene solidale: “Di questo declinare dell’occaso/ ora lo so, lo sento/ che in lui, di me, c’è in verità quel vero/ che mai non nostro, inquieto e solitario,/ scostante forse, insofferente e crudo,/ma la bellezza ha per virtù l’orrore”…
Da un’inattesa fascinazione indotta nel noto poeta anconitano Francesco Scarabicchi dalla presenza nelle Marche di alcune delle opere più significative del pittore veneto Lorenzo Lotto (1480–1557), prende corpo questa nuova raccolta poetica raffinata e fluida come nelle sue corde migliori. Con indubbia esperienza e maestria, come solo un profondo cultore della materia poteva orchestrare, egli incrocia i requisiti di due esistenze che arrivano a chiamarsi e a corrispondersi in un amabile gioco di rimandi allusivi. Il tentativo di esprimere nelle equivalenze all’andamento dei versi un processo alchemico che dalle visioni pittoriche alle suggestioni poetiche mira a convertire il non finito di una espressione iconografica nell’infinita durata della sua emozione, nell’arcano della sua immortalità. La sua è infatti una maniera elegante e delicata di attingere al tormento interiore di un artista parole che nell’artificio poetico spieghino e sublimino la parzialità e la caducità della condizione umana. Indice di una raffinata sensibilità che conosce le asperità della vita e nel contempo la dignità nel sapercele restituire.
L’enigma discreto di Anna Elisa De Gregorio, «Poetarum Silva», 6 ottobre 2016
Mi chiama con i colori della discrezione, dal suo angolo, nel Museo dell’Antico Tesoro di Loreto, La Presentazione al Tempio di Lorenzo Lotto. Mi siedo già sapendo che sosterò qui a lungo: è l’ultima opera del pittore (terminata intorno al 1555) ed è questo che me la rende preziosa. Un lungo travaglio per un quadro non troppo grande (172 x 136,5 cm), non specialmente impegnativo. Non aveva, certo, tante commesse a cui far fronte Lorenzo, nell’ultimo luogo, dove trovò rifugio come “oblato”, nella Santa Casa di Loreto. Quando s’era messo all’opera, erano per lui passati i settant’anni e, di certo, era malato e quasi cieco. Quel quadro gli sarà costato più tempo e fatica del previsto.
Il dipinto appare costruito su due piani, decisamente separati: in basso il pittore descrive la sua visione di un passato, vivo seppure antico, in alto la rappresentazione del suo personale e isolato presente. Nel piano inferiore, vivace nei movimenti e negli sguardi e spento nei colori, una piccola folla, nel tempio ebraico, raccolta in semicerchio, è in attesa. La Madonna sta salendo le scale col bambino, è rivolta verso il sacerdote, nella posizione di protezione e insieme di offerta del proprio figliolo. Ma non è lei il fulcro della rappresentazione sacra, infatti è appartata nell’angolo sinistro. Al centro Lorenzo ha voluto porre un altare, un tavolo quadrato che galleggia a un palmo da terra vestito soltanto da una preziosa tovaglia bianca. E, proprio sotto la tovaglia, ecco spuntare due caviglie seguite dal profilo di due grossi piedi (altri due si intravedono dietro a mo’ di zampe), che possono scendere solo dal tavolo e che sembrano sorreggerlo. Un’allegoria del corpo di Cristo, del suo sacrificio? Oppure un sapiente, ironico gioco dovuto a una, ormai, disappartenenza alle logiche del mondo? Oppure, vecchio, il pittore ha dimenticato un suo progetto iniziale, lasciandolo a mezzo?…
«L’umano nel divino e quei colori spenti/ sono l’ultima incognita che lascio,/ la doppia chiesa ch’è tempio e basilica,/ tra Simeone e il vecchio che s’affaccia/ nel semibuio della scena alta./ Per voi l’enigma di quei piedi umani/ su cui poggia la tavola a mensa vuota./ L’eredità che lascio è un testamento/che non ha parole…», scrive Francesco Scarabicchi riferendosi, appunto, alla Presentazione al Tempio nell’ultima poesia, prima della Clausola, del suo libro dal titolo con ogni mio saper e diligentia, Stanze per Lorenzo Lotto.
L’interrogativo resta intatto; non avrà risposta e così mi piace che sia.
Questo piccolo volume di poesie mi è particolarmente caro, non certo per l’attenzione (non esiterei a chiamarla maniacale) del poeta verso tutta l’opera di Lotto fin dall’adolescenza, che non potrebbe certo bastare alla poesia per illuminarsi, quanto per una immedesimazione totale nell’uomo, nell’artista e nel suo pensiero da parte di Scarabicchi, che si fa medium, solo nella finzione artistica, passivo. In ogni verso ritroviamo Lorenzo, “solitario e febbrile”, è lui che parla in prima persona nel poemetto, è Lorenzo, mai abbastanza compreso e riconosciuto, che crea e soffre, che invecchia, che si sente tradito, che scrive con grande fatica d’occhi il suo prezioso Libro di spese diverse. Una miracolosa rinascita, come se la poesia fosse pietra filosofale, capace di metamorfosi. Un lavoro meticoloso, che, proprio come l’ultimo dipinto di Lotto, ha avuto una lunga gestazione. Possiamo parlare di una totale, poetica, visionaria “compassione”.
I tratti del quadro non sono così decisi, i contorni delle varie figure tremano un po’, in particolare intorno alla profetessa Anna, che è figura umana rilevante più delle altre. Noto che la sua mano sinistra non è ben disegnata, sembra quasi che dalle maniche escano due mani destre, come non finite. C’è gran tristezza nello sguardo, il viso di lei è vecchissimo, stanco, come le braccia, che cadono verso il basso. E la tristezza è trasmessa a tutto il dipinto, sembra che tutti si preparino a un sacrificio in quel tempio ebraico, screditando le parole di serenità che nelle sacre scritture pronuncia Simeone davanti al Bambino: «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo/ vada in pace secondo la tua parola;/ perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza…».
In armonia con questa atmosfera “senza solennità”, è anche il piano alto del quadro (l’interno d’un convento, d’una sagrestia di chiesa?). Il colore è incerto, stinto, di chi ha bisogno de “ochialj da veder luntano”: un frate con la barba bianca, figura di malinconia, viene sorpreso nell’atto di uscire da una porta stretta verso un ambiente freddo, semibuio, come in una sera d’inverno. Sulla sinistra si immaginano un’edicola, dei sedili di legno, una cassapanca. So che è lui, il vecchio Lotto, che sta guardando noi che lo guardiamo. Dando tanto spazio nel quadro a quegli interni desolati, l’intento è quello di indicarci quanto soffra l’abbandono e il vuoto dei suoi ultimi anni? O vuole anticipare a se stesso ciò che lo aspetta nel prossimo domani, nel mondo celeste, a cui pure Lorenzo crede?… Lassù, certo, sembra che tutto stia per scomparire. Non vedo salvezza, non c’è intenzione di luce.
Anche io, adesso, ho gli stessi occhi provati di Lorenzo, ho i suoi stessi anni e la sua solitudine accanto, seduta su una panca di legno ad osservarlo nella sala deserta della pinacoteca, con assoluta commozione. Vivo la sua difficoltà di muovere pennelli, di mescolare colori, di ricordare numeri e segni, di arrischiarsi a salire le scale: «…Senza solennità,/ a bassa luce, nell’impreciso gesto che si compie/ avviene ciò che narra l’evangelio/ e l’ombra dei miei occhi ancora vede,/ se immagino quel tempo e me in esso,/ cronista che già incespica malfermo, ma certo d’aver scelto del futuro/ la via che guida al mondo che resiste,/ la sola che prosegua in tanta notte».
Così termina la poesia L’enigma di Scarabicchi, che ho maldestramente citato e tagliato in due parti (così come ha fatto Lotto con il suo dipinto) dove discretamente il poeta negli ultimi due versi ci indica una strada di salvezza nell’arte, oltre il tempo, oltre il buio.
Il sentimento di pietas è intenso, in ogni parola, come in ogni pennellata del pittore; è così che il nostro sguardo e il nostro ascolto si “converte” a un’intima, individuale bellezza, possibilità di ogni essere umano resistente.
Ho voluto fare questa triangolazione spericolata e irrispettosa, riferendomi solo a un dettaglio sia dell’opera di Scarabicchi che dell’opera di Lotto.
Un inconsueto modo di procedere per suggerire un “ascolto”, senza orologio, del dipinto insieme con tutte le opere di Lorenzo, e nello stesso tempo del poemetto in versi con ogni mio saper e diligentia, dove intensamente si narra proprio di tali opere e di tale personaggio. Siamo davanti ad un interrotto monologo interiore, a un finissimo racconto d’anima.
Per finire l’intrigante gioco di specchi, Francesco Scarabicchi ha scelto, per la copertina del suo libro, proprio la parte superiore del dipinto, dove il frate-poeta-spettatore-lettore sul limite della porta (quella degli inferi, della vecchiaia, della solitudine, della precarietà, della miseria umana) ci guarda e lo guarda per un’ultima volta. Forse le sessantuno “stanze” del poema prendono a nascere proprio da quest’ultimo quadro, memento e “testamento che non ha parole”, quasi in una religiosa ricerca a ritroso.