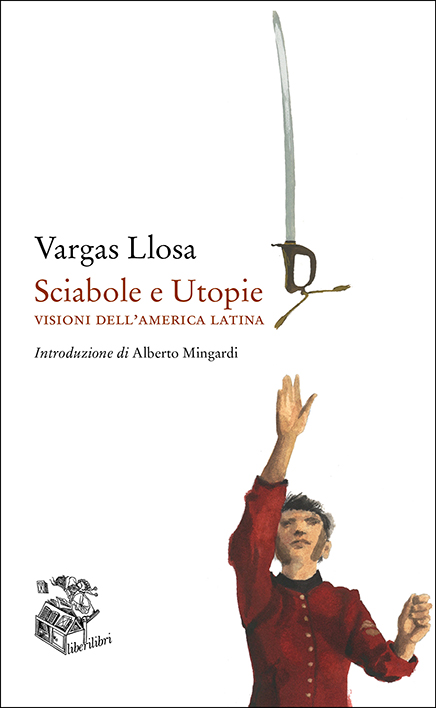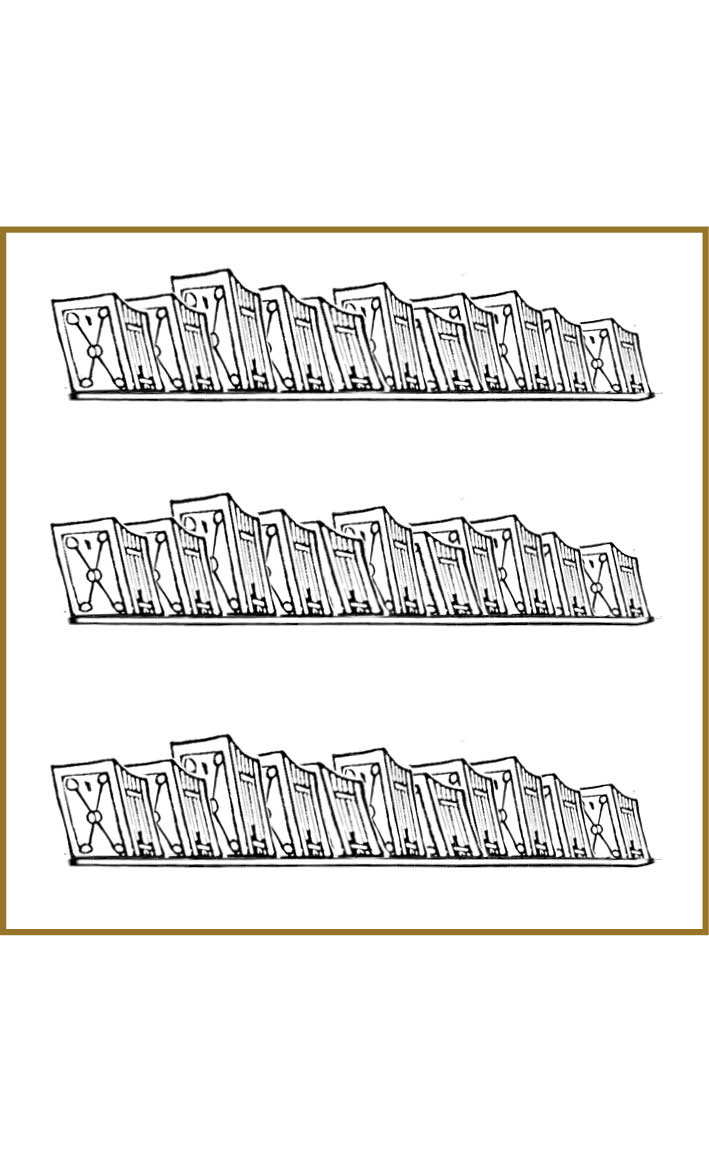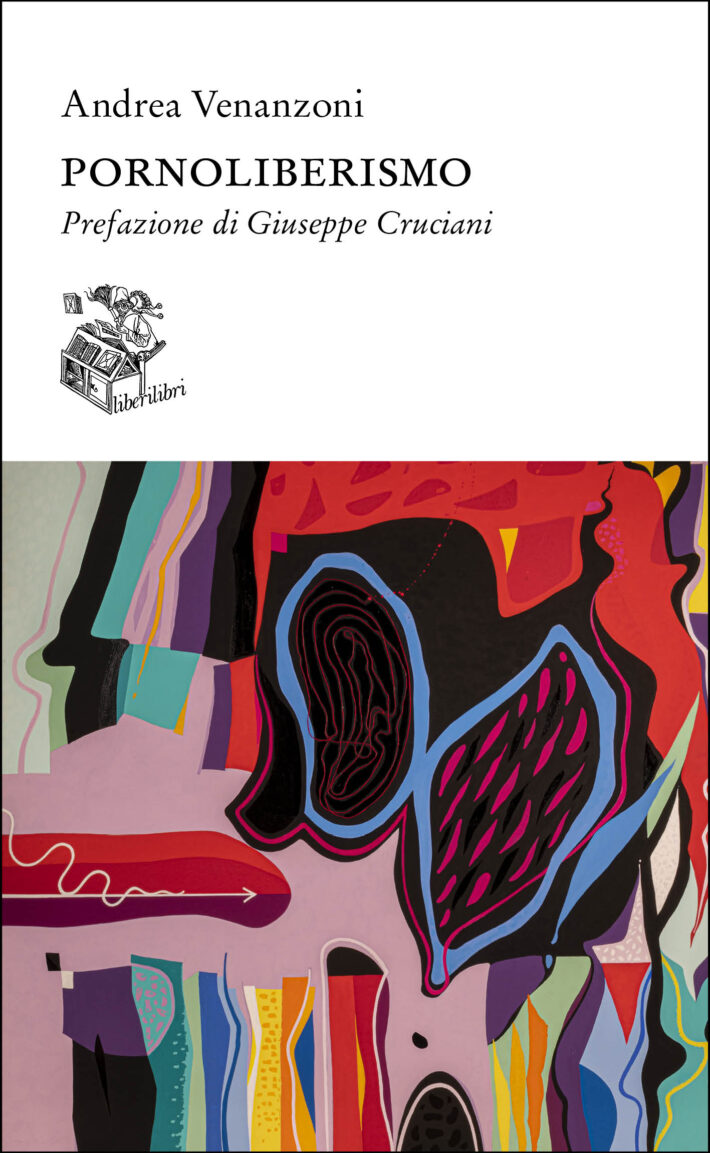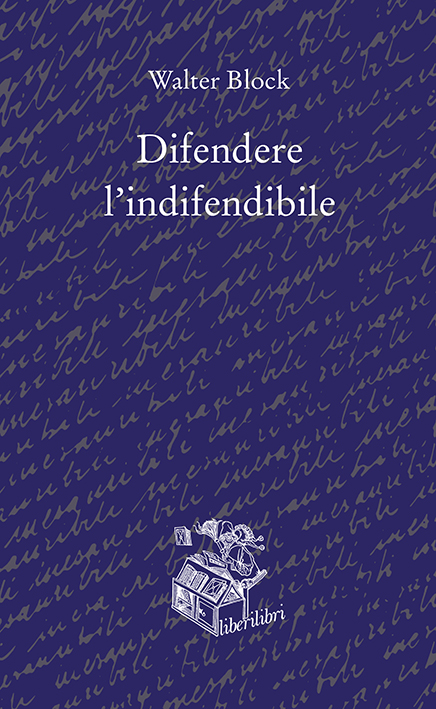In questa sorprendente raccolta, sino ad ora inedita in Italia, di riflessioni politiche e filosofiche, di analisi sociali e culturali, il premio Nobel Mario Vargas Llosa, nelle vesti di critico-narratore, ci dona il suo punto di vista su molti dei più significativi eventi accaduti in America Latina dalla seconda metà del Novecento in avanti, sulle loro radici storiche, sui loro lasciti – spesso tragici –, e sui personaggi talvolta bizzarri che ne sono stati protagonisti. Ma anche, su come questo caos sia stato accompagnato da uno straordinario fiorire di artisti ineguagliabili.
Sciabole e Utopie è un monumento all’America Latina e alla sua complessità eretto da un intellettuale liberale testimone dei regimi autoritari che l’hanno martoriata. Questo testo rappresenta dunque una guida per chi voglia comprendere l’unicità spesso violenta di quella regione del mondo attraverso il pensiero di uno dei suoi più grandi scrittori.
Sciabole e Utopie
Visioni dell'America Latina: monumento alla complessità di un continente eretto da uno dei suoi più grandi scrittori.
Traduzione di Conzuelo Fogante Alessandra Battistelli
Introduzione di Alberto Mingardi
Pagine LXVIII-302
ISBN 9788898094745
Prima edizione 2020
Il prezzo originale era: 20,00 €.19,00 €Il prezzo attuale è: 19,00 €.
Il liberalismo cosmopolita di Vargas Llosa non è affatto un’utopia, di Michele Magno, «Il Foglio», 29 ottobre 2020, pag. 2.
Dopo aver rotto con il marxismo lo scrittore peruviano si è opposto a tutte le autocrazie, indagando la natura violenta del potere e teorizzando un mondo in cui libertà economica e politica sono possibili grazie alla cultura. Una raccolta dei suoi saggi più politici.
“Un uomo forte come Richelieu / ci porterebbe tutti quanti in porto”, recitava la filastrocca cantata nelle bettole parigine alla vigilia del colpo di stato del brumaio (dicembre) 1799. A quel primo modello di stampo napoleonico si sarebbero poi ispirati molti dittatori dei vari totalitarismi fioriti nel Novecento, in Europa come nel continente latinoamericano. Dopo la sua rottura col castrismo all’inizio degli anni Settanta, Mario Vargas Llosa non ha cessato di far sentire la sua voce contro le autocrazie di ogni tipo, al contrario di quei maître à penser che hanno invece scelto – per codardia o convenienza – il silenzio, ovvero la massima espressione di subalternità verso chi detiene il potere. Per questo, in tempi in cui buona parte dell’intellighenzia di sinistra è sedotta dalle sirene del populismo, tace o si rifugia in polemiche astruse contro un mitologico “neoliberismo”, leggere l’autore de Il richiamo della tribù, in cui racconta come ha voltato le spalle alla sua gioventù tinta di rosso, è come aprire una finestra in una stanza piena di fumo. Da ultimo, lo testimonia un volume fresco di stampa, in cui sono raccolti i suoi saggi più politici (Sciabole e Utopie. Visioni dell’America latina, Introduzione di Alberto Mingardi, Liberilibri, 301 pp., 20 euro).
Vargas Llosa, acrobata ideologico, di Diego Gabutti, «Italia Oggi», 17 ottobre 2020, pagg. 24-25.
Prima della cura: «Fídel Castro non è eterno, come non lo era Lenin e niente ci può assicurare che chi gli succederà sarà allo stesso modo onesto, patriottico o lucido». Dopo la cura: «Occorre fare in modo che l’umanità viva, finalmente, in un mondo in cui i Fidel Castro siano anacronismi plateali: esattamente come lo sono, ora, il cannibalismo e la tratta degli schiavi».
Comunista (come tutti, o quasi) in gioventù, negli anni cinquanta Mario Vargas Llosa, Premio Nobel per la letteratura nel 2010, stravedeva (sempre come tutti, o quasi, i suoi contemporanei) per le orazioni di Jean-Paul Sartre, maestro d’engagement, e tuonava contro l’escapismo reazionario di Jorge-Luis Borges. Già allora, naturalmente, il futuro autore di Conversazione nella cattedrale e delle Avventure della ragazza cattiva era di gran lunga più interessato alla buona letteratura che alla cattiva filosofia e sapeva benissimo che tra Sartre e Borges non c’è semplicemente gara. Ma prima di poterlo ammettere anche soltanto con se stesso, gli toccò arruolarsi nella filibusta dell’utopismo latinoamericano (di nuovo come tutti, o quasi, gl’intellettuali latinos del suo tempo, gli anni di Péron e dei Castro Brothers).
Utopia, all’epoca, era la parola di passo per accedere alle meraviglie dell’ideologia sudamericanista (cioè a quello che suo figlio, Alvaro Vargas Llosa, avrebbe battezzato, in un celebre e geniale pamphlet, Il manuale del perfetto idiota sudamericano, Bietti 1997). Utopia (scrive Vargas Llosa in uno dei saggi raccolti in Sciabole e Utopia, da qualche giorno in libreria) era «la robusta tradizione che, da un estremo all’altro del continente, accompagnava la storia dell’America Latina e che, invece di scomparire, era andata accentuandosi a partire dall’emancipazione: il rifiuto del reale e del possibile, in nome dell’immaginario e della chimera. «Nessuno» (postilla Vargas Llosa) «l’ha descritta meglio del poeta peruviano (Augusto Lunel nelle prime righe del suo Manifiesto: «Siamo contro tutte le leggi, iniziando dalla legge di gravità”».
Ex comunista, liberale rinato, Vargas Llosa è un intellettuale molto più proficuamente impegnato a difendere e diffondere libertà e libere istituzioni di quanto si sia mai (e sempre vanamente) impegnato Sartre, col suo engagement da discoteca totalitaria, in favore di satrapie, tirannie, camere di tortura e lager (da Saint Just a Salvador Allende e Augusto Pinochet, sono poi queste le forme pratiche assunte dalle «utopie realizzate», in America latina come dappertutto). Bibliotecario a Buenos Aires sotto il regime descamisado d’Evita e Juan Péron, Borges rifiutò per tutta la vita di pronunciare anche soltanto il nome del caudillo justicialista argentino e della sua signora. A differenza di Borges, che la detestava, Vargas Llosa non ha mai giudicato con disprezzo la politica (benché sia proprio questo, tirate le somme, e alla fine di tutte le fiere novecentesche, il solo modo onesto di giudicarla).
Nel 1990, da leader d’uno schieramento liberale, si presentò alle elezioni in Perù, e per poco non la spuntò contro Alberto Fujimori (un giapponese, detto approssimativamente el Chino per le sue origini asiatiche) che (in nome , e con la scusa; della lotta al terrorismo maoista di Sendero Luminoso, un esercito di feroci assassini che in pochi anni aveva allineato negli obitori oltre settantamila morti ammazzati) trasformò il Perù in una dittatura di destra altrettanto feroce.
Da allora sono passati trent’anni, Sendero Luminoso è stato sconfitto, Fujimori è in esilio inseguito da mandati di cattura, il Perù è tornato alla democrazia, Fídel è «finalmente morto» (come una volta Vargas Llosa s’augurò pubblicamente) e «la tradizione» utopica dell’America latina si è ridotta a due sole enclave totalitarie: il bordello comunista cubano e l’horror politico, economico e morale venezuelano.
Tutti questi anni non sono passati invano. Vargas Llosa, tra il 1990 e oggi, ha scritto alcuni libri memorabili sull’America del sud e sul liberalismo, a cominciare dal più recente, Il richiamo della tribù, Einaudi 2018, che è allo stesso tempo un grande memoir e una storia avvincente dei principali pensatori liberali, da Adam Smith a Ludwig von Mises (di cui Rubbettino, aprendo una parentesi, ha appena mandato in libreria un testo classico, Socialismo, apparso in prima edizione nel 1922).
A proposito di von Mises, e della politica attiva, che per un po’ lo tenne sotto incantesimo, ma soprattutto a proposito del liberalismo che aveva ispirato la sua candidatura contro Fujimori, Vargas Llosa scrive che «il grande pensatore liberale si oppose sempre all’esistenza dei partiti liberali perché, a suo giudizio, queste formazioni politiche, nel pretendere di monopolizzare il liberalismo, lo snaturavano, incasellandolo negli stretti stampi delle lotte di partito per raggiungere il potere.
Secondo von Mises, la filosofia liberale dev’essere piuttosto una cultura generale condivisa da tutte le correnti e i movimenti politici che coesistono in una società aperta e a sostegno della democrazia; un pensiero che irrora allo stesso modo i socialcristiani, i radicali, i socialdemocratici, i conservatori e i socialisti democratici».
È così, stringi stringi, che la vede anche Borges, anarcoconservatore, letterato puro, indifferente alla politica dei partiti ma fermo difensore (Popper citando) della libertà contro «i suoi nemici», tutti dal nome impronunciabile, come i coniugi Péron. Vargas Llosa (come scrive Alberto Mingardi nell’introduzione a Sciabole e Utopie, un lungo e illuminante saggio su Vargas Llosa) è uno dei rari ma fortunatamente non rarissimi intellettuali del Novecento, di «grammatura» a volte pari ma più spesso «inferiore alla sua», che a una svolta o l’altra della vita si sbarazzano delle convinzioni invecchiate e, «cambiando idea», ne abbracciano di nuove.
È passato dalla sinistra estrema al liberalismo, da Sartre a Borges, dall’insensatezza alla ragione, dalla politica attiva al suo superamento, dalla letteratura impegnata in favore dei tiranni alla letteratura impegnata in favore della libertà, dalle idee rococò a quelle sobrie. Spiega Mingardi: «Liberali non si nasce, semmai si diventa. Tendiamo «naturalmente» a essere gregari, a privilegiare le relazioni faccia-a-faccia, a cercare «mani visibili» per spiegare quel che accade attorno a noi. La convinzione centrale del liberalismo è che pochi principî giuridici, in buona sostanza diritti di proprietà privata e rispetto dei contratti, possono «garantire un adattamento reciproco delle azioni dei singoli individui» che mette gli uomini in condizione di «rendersi reciprocamente utili» pur «mantenendo ciascuno i suoi scopi». Prima della cura, gli incubi dell’utopia; dopo la cura, il vasto e inesplorato mondo dei diritti, e della realtà.
Il libero mercato per vincere i “caudillos” sudamericani, di Luigi Mascheroni, «il Giornale», 11 ottobre 2020, pagg. 24-25.
Da un giovanile semimarxismo alla cultura aperta e all’economia di mercato, riducendo il collettivismo all’individuo: autobiografia intellettuale di un romanziere da Nobel.
Prima ci fu l’infatuazione per Fidel Castro e l’iscrizione al Partito comunista peruviano, nel ’53, al primo anno di Università («Eravamo pochi ma assolutamente settari, molto dogmatici, completamente stalinisti»), poi la scoperta dell’Europa e le letture economiche e filosofiche, da Adam Smith a von Hayek, quindi la delusione per la propaganda e le violenze cubane, fino all’approdo liberale e liberista. Mai più caudillos in Sudamerica (e speriamo neppure i loro supporter qui da noi). Da Sartre a Berlin, dal foco guerrillero alle dottrine di Hernando de Soto, fino alla deregulation di Margaret Thatcher. Percorso insolito, per uno scrittore della Cordigliera.
È quello di Mario Vargas Llosa, uomo dal carattere non facile e capace di cambiare idea e visione del mondo, il quale ha riempito la sua vita di scrittura, che gli ha regalato il Nobel, nel 2010, e di politica, che lo ha portato a candidarsi presidente della coalizione di centro-destra alle elezioni del 1990 in Perù, sconfitto da Alberto Fujimori. Il quale poi, nemesi elettorale, attuò un colpo di Stato.
Alla fine, è più facile che i sopracciò dei salotti comodi perdonino a Vargas Llosa l’amore per la carne e la corrida, piuttosto che l’approdo al liberalismo contro l’economicismo socialista. Don Mario, don Mario… te la sei cercata.
Ed eccole qui le prove del guevarismo tradito, della scelta pro mercato e il j’accuse contro tutti i dittatori e lìderissimi (di destra e di sinistra, da Perón a Hugo Chávez): sono gli scritti politici di Mario Vargas Llosa – «lettere aperte» ai vari generali golpisti, articoli, conferenze… – tradotti per la prima volta in Italia e raccolti sotto il titolo Sciabole e Utopie. Visioni dell’America Latina (Liberilibri, pagg. 302, euro 20; traduzione di Conzuelo Fogante e Alessandra Battistelli) con una solida introduzione di Alberto Mingardi.
In parte riflessioni filosofiche, in parte analisi sociali, in parte excursus storici sulle più recenti vicende sudamericane, i testi – risalenti al periodo compreso fra gli anni Settanta e la metà degli anni Duemila, quando Vargas Llosa aveva già abbandonato il suo Perù per la Spagna – compongono una sorta di romanzo politico in forma di pamphlet in difesa della democrazia e del liberalismo.
Uomo che ha vissuto sulla propria pelle le follie del verbo rivoluzionario marxista, Vargas Llosa smaschera le tragiche utopie del socialismo in salsa latinoamericana: lavoro forzato, soppressione delle libertà personali, povertà generalizzata (tranne una piccola classe di privilegiati burocrati), censure, sfruttamento dei più da parte dei pochi…
Da (sud)americano che ha conosciuto l’Europa, dove vive da tempo, pur riconoscendo limiti e storture, rende giustizia a quei Paesi in cui la democrazia va di pari passo all’economia di mercato, le libertà individuali sono maggiori e il potere molto più controllato, e non alla mercé del primo generale o rivoluzionario.
E da studioso delle teorie economiche, oltre che romanziere, prova a ripulire la cattiva fama del (neo)capitalismo, consigliando agli Stati più fragili e ideologizzati del suo continente alcune ricette liberali: privatizzare le imprese, liberalizzare i prezzi, controllare l’inflazione, introdurre le economie nazionali nei mercati internazionali. Chi l’ha detto che la globalizzazione è il male?
E tutto ciò – oltre che con la prosa del grande narratore – sostenuto senza irrigidimenti, senza fanatismi, senza utopie di segno uguale e contrario al comunismo marxista.
Tra le gemme del libro si segnalano: una elegante intemerata contro chi, in Europa, ancora nel 2004, sosteneva che il modo migliore per ottenere «concessioni» da Castro fosse il dialogo e la dimostrazione di amicizia verso la sua tirannia (Le puttane tristi di Fidel). Il garbo con cui smonta l’inutile antiamericanismo di tanta Sinistra. E la sua granitica professione di fede liberale: «Il liberalismo – scrive in una conferenza del 2005 all’American Enterprise Institute for Public Policy Research di Washington – non è un’ideologia, vale a dire una religione laica e dogmatica, bensì una dottrina aperta che evolve e si piega alla realtà, anziché provare a forzare la realtà affinché questa si pieghi ad essa». Democrazia politica, economia di mercato e difesa dell’individuo di fronte allo Stato: è la trinità liberale. «I fondamenti della libertà sono la proprietà privata e lo Stato di diritto, il sistema che garantisce le minori forme di ingiustizia, che maggiormente produce progresso materiale e culturale, che meglio argina la violenza e che più rispetta i diritti umani. Per tale concezione del liberalismo, la libertà è una sola e la libertà politica e la libertà economica sono inseparabili come il diritto e il rovescio di una medaglia». Una verità degna di un Nobel.
Contro i tiranni di ogni colore, di Giancristiano Desiderio, «Corriere della sera», 25 settembre 2020, pag. 49.
La casa editrice Liberilibri sta pubblicando diverse opere di Mario Vargas Llosa inedite in Italia. All’inizio dell’anno è uscito Sogno e realtà dell’America Latina, ora è la volta di Sciabole e Utopie, con l’introduzione di Alberto Mingardi.
Sono 31 saggi che ripercorrono tanto la storia moderna e tormentata dell’America Latina quanto gli stessi tormenti dello scrittore premio Nobel che oggi, scrive Mingardi, è «il massimo intellettuale pubblico liberale dei nostri tempi», dopo aver attraversato in gioventù il dogmatismo marxista.
Il lettore troverà tra le «pagine sparse» di Vargas Llosa anche alcune lettere: una indirizzata a un dittatore argentino, il generale Jorge Rafael Videla, e una inviata a Fidel Castro sul caso del poeta Heberto Padilla perseguitato a Cuba (in calce si leggono anche i nomi di Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino, Alberto Moravia, Dacia Maraini, Giulio Einaudi, Rossana Rossanda).
Oltre alla politica c’è tanta letteratura: come se per scappare dai regimi autoritari gli scrittori, da Borges a García Màrquez, avessero dovuto inventare un mondo parallelo più vero per riconquistare una realtà infiammata. Senza letteratura non ci sarebbe, forse, nemmeno libertà. Sarà per questo che Vargas Llosa iniziò così il suo discorso a Stoccolma: «Ho imparato a leggere a cinque anni, nella classe di frate Justiniano, nel Collegio de la Salla, a Cochabamba, in Bolivia. È stata la cosa più importante che mi sia successa nella vita».
Il libro di Vargas Llosa Sciabole e Utopie è edito da Liberilibri (introduzione di Alberto Mingardi, traduzione di Alessandra Battistelli e Conzuelo Fogante, pp. LXVIII-302, euro 20).
Mario Vargas Llosa: la libertà è sempre umile, non rivoluzionaria, intervista di Alberto Mingardi, «Corriere della sera», 25 settembre 2020, pagg. 48-49.
«Il lockdown per me è stato una meraviglia. Leggevo per dieci ore filate al giorno, senza interruzioni. Ho potuto rileggere cose che da tempo desideravo riprendere in mano…». Al sentirsi chiedere che cosa abbia riletto, Mario Vargas Llosa sorride. «Madame Bovary. Ho letto un’altra volta Madame Bovary e come sempre ne sono rimasto accecato. Flaubert è il primo romanziere moderno. Ha insegnato a tutti noi che il narratore è il primo personaggio che qualsiasi scrittore si deve inventare».
Vargas Llosa ha trascorso i mesi della pandemia a Madrid. Non ha «mai avuto paura, nonostante l’età (84 anni, compiuti a marzo) mi confini nella categoria delle persone fragili». Questo, sul piano personale: sul piano politico, invece, il Nobel peruviano ha espresso preoccupazione per le sorti dell’economia e dei diritti civili con un manifesto, Que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo, promosso dalla Fundación Internacional para la Libertad (Fil). Sono temi a cui Vargas Llosa si dedica da anni, come testimonia Sciabole e Utopie, una raccolta dei suoi scritti politici uscita per Liberilibri. «Mi spaventa il disprezzo diffuso per la politica. Le persone migliori se ne tengono alla larga: la considerano una cosa sporca. È così in Perù, in Spagna, sono sicuro sia così anche in Italia. Ma se di politica si occupano solo i peggiori, avremo pessime scelte politiche. In questo modo, il populismo diventa una profezia che si autoavvera».
Nella pandemia, molti hanno ammirato la capacità di reazione del governo cinese…
«La Cina ha grandi responsabilità. Ha occultato fatti e informazioni che avrebbero consentito agli altri Paesi di prepararsi per tempo. Questo è stato possibile per la natura dello Stato cinese».
Quando le cose hanno preso il verso sbagliato?
«Tutt’oggi non sappiamo che cosa sia avvenuto di preciso, in Cina, ma sappiamo che alcuni scienziati avevano scoperto l’esistenza e la pericolosità di questo nuovo coronavirus. Che ha fatto il governo? Li ha costretti al silenzio, facendo perdere a tutto il mondo settimane, se non mesi. Mi ha ricordato quel documentario su Chernobyl, dal quale emergeva che Gorbaciov tentò di comprendere davvero ciò che era avvenuto. Ma non riuscì a identificare cause e responsabilità. Non c’era modo: all’interno del sistema tutti mentivano. A differenza che in un’economia di mercato, in una società burocratica non esistono indicatori di successo che prescindano dal racconto dei protagonisti. I funzionari debbono difendere la propria posizione dalla volontà arbitraria di chi sta sopra di loro e mentono. Piano piano, la menzogna diventa regime».
La Cina comunista, insomma, le sembra tutto fuorché un modello…
«Una volta di più dovremmo avere capito l’importanza della libertà. E specialmente che la libertà o è “integrale” o non funziona: o la si può esercitare, simultaneamente, in tutti i campi, o non esiste. Senza Stato di diritto è impossibile avere davvero un’economia di mercato e, quando le istituzioni fondamentali dell’economia di mercato (proprietà privata, libertà contrattuale) vengono meno, non può esserci davvero Stato di diritto. La libertà è una sola».
Oggi, questo liberalismo appare come una sorta d’utopia…
«Al contrario. Una cosa che il liberalismo ti insegna è a essere realista. In questo senso: a capire che gli schemi intellettuali, per quanto possano sembrare perfetti, devono sempre adattarsi alle circostanze particolari, che tendono a essere più complesse di quanto persino i pensatori più acuti possano immaginare».
In politica, al contrario che nei romanzi, l’originalità è un difetto?
«Sì. Più che la creatività, in politica, serve umiltà. Pensiamo ad Adam Smith. Smith aveva chiarissimo ciò di cui i Paesi hanno bisogno per progredire. La concorrenza è essenziale al progresso economico, e pure a quello civile e politico. Ma Smith sapeva anche che le idee della concorrenza devono attecchire, nella società, diventare parte della cultura comune, per produrre effetti duraturi. Sono le riforme che devono adattarsi allo stato delle cose, e non dobbiamo invece presumere che le cose si adattino istantaneamente ai desideri dei riformatori».
Che cosa è cambiato dai tempi di Smith?
«Noi abbiamo un grande vantaggio. Per la prima volta, oggi sappiamo che cosa è necessario fare affinché un Paese progredisca. Per la prima volta nella storia un Paese può scegliere, se essere ricco o essere povero, attraverso le istituzioni che si dà. È un’aberrazione che in tanti continuino a scegliere la povertà».
È la meritocrazia che rende accettabili le diseguaglianze?
«Se le persone hanno la percezione che in linea di massima agli alti guadagni corrispondono meriti e voglia di lavorare, le accettano. Questo è il modello americano, o almeno lo era prima di Trump. È un modello che ha attirato, non a caso, milioni di persone da tutto il mondo: desideravano una chance per potere migliorare la propria posizione e la trovavano negli Stati Uniti».
L’anno prossimo ricorrono i quarant’anni dalla pubblicazione di un suo grande romanzo, «La guerra della fine del mondo». Cosa ci insegna la storia dei rivoltosi di Canudos, pensando anche ai populismi contemporanei?
«Il caso di Canudos è emblematico di tanti altri, in America Latina o in Africa. Era una comunità così isolata e lontana dal resto del Paese, da avere dei sentimenti, un’identità totalmente diversi. I campesinos di Canudos erano influenzati da preti fanatici, che li avevano messi in guardia contro il potere dei massoni. Si erano convinti che il giorno in cui in Brasile si fosse instaurata la Repubblica, a prendere il potere sarebbe stato, letteralmente, il diavolo. Sembra una follia ma per quella gente così umile, così ignorante, senza contatti col resto del mondo, non lo era affatto».
Erano lontani dall’élite politica, ma anche viceversa.
«Il Brasile colto, quello moderno, non li comprende per nulla. Interpreta la loro ribellione come un’operazione dell’Inghilterra e dei monarchici per sabotare la Repubblica. Euclides da Cunha, che pure partecipa di persona alla quarta spedizione contro i rivoltosi, pensa che siano un movimento politico. L’elemento paradossale della storia è proprio questo: che è la parte civilizzata del Paese che adotta una visione cospiratoria, i campesinos le sono così incomprensibili che pensa di avere a che fare con un complotto internazionale…».
In qualche modo questa incomunicabilità si ripresenta anche nelle discussioni contemporanee, nella contrapposizione fra popolo e élite, nel riproporsi dei nazionalismi?
«Il nazionalismo si basa su un fatto naturale. Le persone si sentono meglio in mezzo ad altre che somigliano a loro. Ma su questa base si costruisce il nazionalismo politico, che è un anacronismo…».
Eppure i nazionalismi sono sempre alla ribalta.
«L’Unione Europea è uno strumento per dissolvere, poco a poco, in un modo molto prudente, le nazioni tradizionali. Grazie alla globalizzazione, i Paesi sono sempre più dipendenti l’uno dall’altro. Che senso ha, ai nostri giorni, esacerbare le identità nazionali? Serve solo alla costruzione del consenso. In Russia il nazionalismo ha sostituito il socialismo reale. In Bielorussia è il marchio di una dittatura fuori dal tempo. Forse c’entra anche la fine del comunismo…».
Perché?
«Il comunismo ha perso attrattiva come formula di giustificazione della dittatura. È un modello la Corea del Nord? Il Venezuela? Oggi sappiamo come si fa a uscire dalla povertà: il socialismo non è un’opzione, non c’è sviluppo senza economia di mercato. È drammatico il caso dei Paesi di quello che un tempo si chiamava Terzo Mondo, dove con strepitoso cinismo piccole oligarchie sfruttano la gran maggioranza della popolazione, in cambio di che? Di nazionalismo. Ripagano lo sfruttamento con un sentimento di identità. Questo è avvenuto tante volte, anche in America Latina».
Perché gli intellettuali restano sempre affezionati, invece, a ipotesi rivoluzionarie?
«Gli intellettuali sognano sempre il paradiso terrestre. Non si può aspirare all’assoluta perfezione dell’opera d’arte, nei fatti sociali ed economici. Quando lo si fa, si finisce per esigere un potere assoluto, con l’obiettivo di rifare gli uomini a immagine e somiglianza di un ideale. È così che si crea non il paradiso ma l’inferno in terra. Gli intellettuali non accettano la mediocrità, ma in politica la mediocrità è la vera civiltà».
Vent’anni fa lei ha corso per la presidenza del Perù, provando a passare dalla predicazione alla pratica liberale. Cosa rimane di quell’esperimento?
«Per me è stata un’esperienza affascinante. Non ho mai avuto ambizioni politiche. Il mio sogno, sin da bambino, era diventare uno scrittore. Mi trovai a capo di un movimento popolare perché mi ero opposto alla nazionalizzazione delle banche e delle assicurazioni proposta dal presidente Alan García. Quella legge, la fermammo. A un certo punto mi illusi, mi feci prendere dal sogno di una candidatura liberale alla presidenza. Facemmo tanti errori ma alcune idee misero radici, non si può dire che sia stato un fallimento completo».
In «Sciabole e Utopie» ci sono anche suoi scritti giovanili, con idee che ha molto rivisto nel tempo. Eppure, a differenza di altri, è sempre attentissimo, per così dire, a lasciare traccia del proprio passato.
«Credo, come dice Karl Popper, che si proceda per tentativi ed errori. Si scrive, si fanno ipotesi e, inevitabilmente, si sbaglia. L’importante è sapersi correggere».
Tutti sanno che lo scrittore più caro a Mario Vargas Llosa è Flaubert. Ma chi è il suo saggista preferito?
«Isaiah Berlin. Ho per Berlin un’ammirazione straordinaria. Vedo che il “Times Literary Supplement” lo attacca, dicendo che è superficiale. Fossero tutti superficiali come Berlin…».
Lei ha raccontato una cena con Margaret Thatcher durante la quale alcuni intellettuali di prima fila la sottoposero a una sorta di esame. Berlin era fra questi.
«Sì, Berlin era seduto di fianco alla Thatcher. Lei aveva questo modo un po’ imperioso di rivolgersi a tutti, ma nei confronti di Berlin era quasi deferente. All’esame lei se la cavò meravigliosamente. Fijate si no es triste: tutti i primi ministri inglesi ricevono una laurea ad honorem dalla loro università, ma Oxford si rifiutò di conferirla alla Thatcher. Fu orribile: era una ragazza di mezzi modesti che fece la carriera universitaria grazie a borse di studio. Vivevo a Londra all’epoca, l’ho visto con i miei occhi: l’Inghilterra si stava spegnendo. E questa donna, combattendo contro tutto e tutti, la trasformò nel Paese più dinamico d’Europa».
Qualcuno ha scritto: solo due scrittori preferiscono la Thatcher a Fidel Castro, Philip Larkin e Mario Vargas Llosa.
«Non sapevo di Larkin ma mi fa piacere. È un grandissimo poeta».